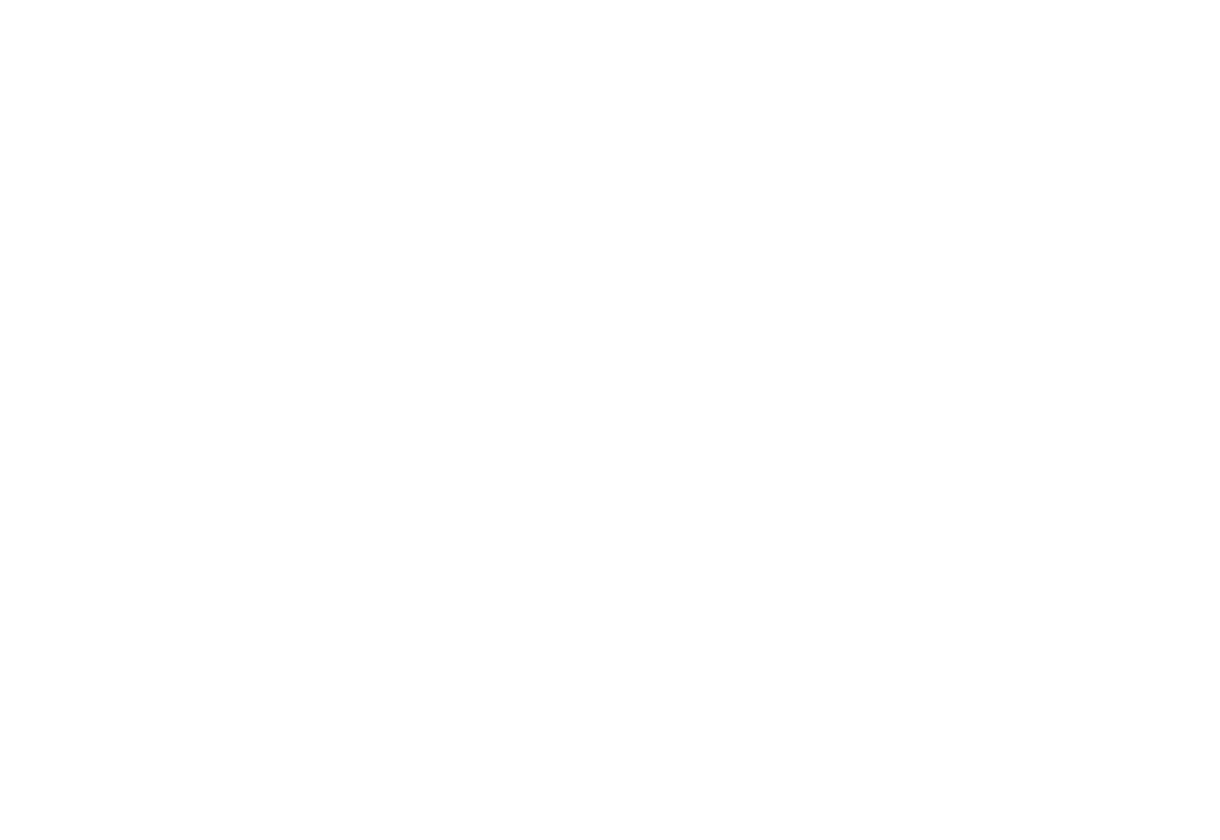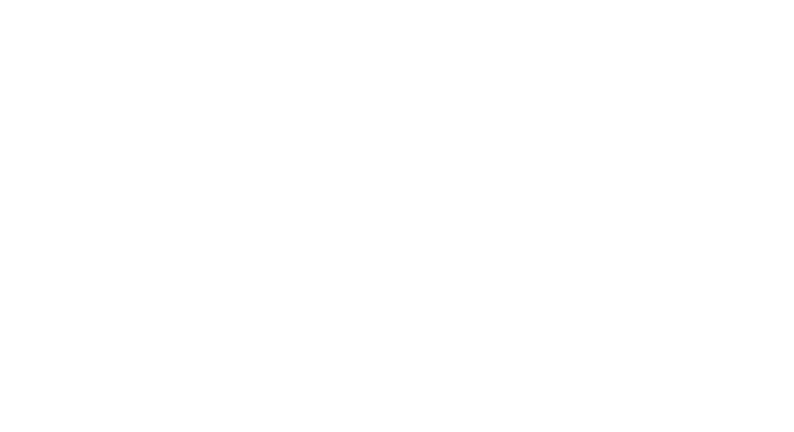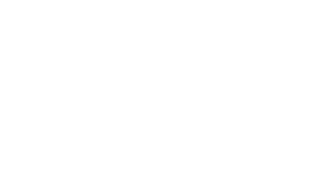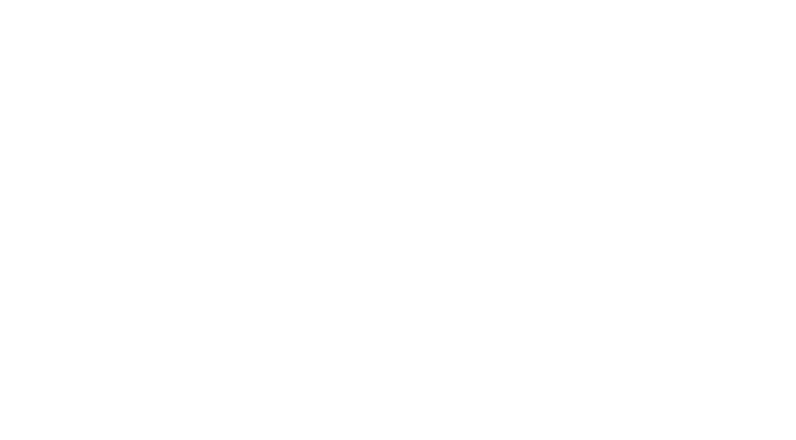“Un ebreo in camicia nera” di Paolo Salom
"Un ebreo in camicia nera" di Paolo Salom racconta la vicenda paradossale di un padre raccontata dal figlio per la Giornata della Memoria.
Paolo Salom
In occasione della Giornata della Memoria pubblichiamo un estratto del libro di Paolo Salom, una storia autentica e paradossale che è anche un intimo confronto tra il padre protagonista e il figlio che lo racconta.
Marcello era un bambino dall’aspetto gracile ma sano. Aveva una testa grande che, nei primi mesi di vita, sembrava sproporzionata rispetto al resto del corpo. Gli occhi erano chiarissimi, come la pelle: così bianca che sembrava trasparente e si aveva quasi l’impressione di poter osservare vene e muscoli al di sotto. Ma ciò che colpiva l’attenzione di tutti era senz’altro quello che stava sopra il collo. Il capo, enorme, che già si tingeva di un rosso acceso, per via dei geni materni: nella famiglia di Galeazzo non si ricordavano, infatti, né biondi né casi di rutilismo. Nelle prime settimane di vita, il nonno si era anche preoccupato: si chiedeva se il primogenito avesse qualche difetto congenito. Ma nonna Aurica lo zittiva con un ringhio e la cantilena tipica degli ashkenaziti: «Capelli rossi normali in mia famiglia, groys kop, testa grande, significa intelligenza!». Tuttavia, questa caratteristica, allungava le altre parti del corpo assumendo negli anni l’aspetto di un fenicottero, di uno stambecco e infine di un tipico ebreo dell’Europa orientale, anche se più alto della media: gambe e busto ridotti alle ossa, spalle spigolose, quasi fossero grucce appendiabiti.
Marcello rimase per tutta l’infanzia e l’adolescenza così magro che, incontrandolo a spasso con il padre o con la madre, tutti affermavano, senza tanti infingimenti, come era tipico degli ebrei del luogo: «Che bel bambino: certo, dovreste farlo mangiare di più!». La dieta in famiglia, in effetti, era piuttosto monotona e legata alla tradizione ashkenazita. Dunque, tanto brodo di pollo, patate e, il Sabato, borsch e gefilte fish (soltanto al rientro in Italia sarebbe virata verso le consuetudini mediterranee: pasta, verdura e qualche volta carne). Marcello non apprezzava molto, ma le alternative erano inesistenti nella Romania dell’epoca. C’era tuttavia una specialità che mio padre gradiva, i cetrioli in salamoia, allora conservati in grandi botti che sprigionavano un aroma pungente che impregnava tutto il quartiere dei pizzicagnoli. E un paio di gerkins e una pagnotta erano in genere la merenda che il piccolo Marcello si portava a scuola. Gli altri bambini avevano spesso dei succulenti panini con prosciutto o salame. Ma in casa Salom, per rispetto alle tradizioni e alla religiosità dei Nathansohn, non si mangiava maiale (Galeazzo però, quando era solo e si trovava in mezzo ai gentili, non esitava ad assaggiare i cibi proibiti, come peraltro aveva sempre fatto in Italia).
In classe Marcello era un bambino tanto silenzioso quanto attento e portato allo studio. Eccelleva soprattutto in italiano, lingua che di fatto utilizzava soltanto con la maestra e con i compagni. Con suo padre parlava in dialetto padovano; con la mamma alternava yiddish e romeno; con i concittadini (non ebrei) di Galatz scambiava ben poche parole: in genere, oltre agli insulti, le interazioni avvenivano solo per mezzo delle mani e il più delle volte erano monologhi in romeno visto che Marcello aveva sempre la peggio e non c’era davvero granché da dire. Inoltre, trascorreva interi pomeriggi a leggere la Torah in ebraico biblico sulle ginocchia del nonno Daniel Nathansohn, che lo adorava trattandosi del primo nipote maschio. Insomma, la confusione nel suo giovane spirito doveva essere notevole in quegli anni così importanti per la formazione. Non soltanto per via dei tanti idiomi differenti cui era esposto, ma anche per l’educazione che gli veniva impartita: molto legata a tradizioni e religione con i nonni materni; di stampo cattolico preconciliare a scuola. Per assurdo, però, il conflitto tra le due culture, a Galatz, non era affatto esplosivo. Marcello, tra i figli dei diplomatici o dei commercianti che erano la maggioranza degli iscritti, si trovava benissimo. Nessuno lo maltrattava, non c’era (almeno allora) un antisemitismo di Stato importato dall’Italia. E la maestra lo considerava né più né meno per i suoi risultati scolastici, educazione religiosa compresa.
Dopo il 1938, e ancor più dopo il 1943, tutte le nozioni sui Vangeli, la storia di Gesù, il nome dei vari santi e, insomma, tutta la vasta nomenclatura cristiana, oltre al saper recitare preghiere come l’Ave Maria o il Padre Nostro, gli sarebbero venuti utili al punto di salvargli, letteralmente, la vita. Tornando agli anni romeni, i bambini della generazione di mio padre erano liberi, molto più di quelli odierni: nessuno si preoccupava di accompagnarli a scuola dopo il primo giorno; fatti i compiti (sullo studio gli ebrei non lasciavano granché spazio alla scelta), i ragazzini uscivano di casa e ronzavano per il quartiere in schiere più o meno assortite ma con una separazione netta tra maschi e femmine. Erano capaci di prendere il tram da soli e i più grandicelli, i «capi» riconosciuti di ciascuna banda, badavano ai più piccoli. Qualche volta giocavano al pallone ma questa non era una passione più che tanto condivisa. E poi c’era il problema della sfera: nessuno ne possedeva una e giocare con un agglomerato di stracci, tenuti insieme con un cordino che si disfaceva di continuo, non era affatto divertente. Certo, tra gli «altri», i ragazzi cristiani (romeni e italiani figli degli espatriati), era forse il gioco più popolare.
Ma avventurarsi nel territorio dei goyim non era mai una buona idea e in genere finiva (male) non appena i bambini ebrei venivano riconosciuti e inseguiti ben oltre i confini stabiliti. Marcello, inoltre, non era molto agile o portato per i giochi fisici, e in questo era senz’altro un Nathansohn. Suo padre, al contrario, dotato di un bel personale, alto, magro ma ben fatto, dava mostra di un’attitudine al movimento e una coordinazione che impressionava sempre moglie e suoceri. I bambini erano dunque «liberi» – i genitori li svegliavano al mattino e li mettevano a letto la sera, il resto del tempo era più o meno affare loro – e potevano anche essere spediti da soli in un altro Paese. In verità, non saprei dire se questa fosse una consuetudine della famiglia Salom-Nathansohn; comunque, passati i sette anni, Marcello scoprì che, avendo dei parenti anche in Italia, gli toccava passare con loro le estati. Galatz, tuttavia, non era ben collegata al resto dell’Europa. L’unico modo per partire era prendere un bastimento che scendeva lungo il Danubio, affrontava il Mar Nero, attraversava i Dardanelli e infine, doppiate le isole greche, risaliva l’Adriatico fino a Venezia. Affidato all’equipaggio, il bambino dai capelli rossi e la cintura ben stretta intorno alla vita perché non cadessero i pantaloni, trascorreva più o meno dieci giorni sulla nave, annoiandosi tantissimo e trascorrendo il tempo a salire e scendere dai ponti, curiosare negli angoli dimenticati e pregare che non ci fosse mare grosso: in quel caso, si metteva sotto le coperte della sua brandina di seconda classe e cercava di dimenticare dove fosse, visto che il movimento provocato dalle onde lo terrorizzava.
Marcello non riuscì mai a superare questa fobia: nei primi anni Settanta, a Parigi per una visita di controllo al terzogenito Marco, operato ai piedi, io e mio fratello maggiore Daniele (così chiamato in onore di nonno Nathansohn) lo convincemmo a portarci in gita su un bateau-mouche che percorreva la Senna. Eravamo ancora fermi alla banchina quando il movimento ondulatorio indotto dai passeggeri che si imbarcavano gli causò un attacco di panico e così, con nostra immensa delusione, ci esortò a scendere dopo nemmeno cinque minuti. Arrivato al porto di Venezia, un ufficiale di bordo lo consegnava a nonno Girolamo e nonna Gina, i genitori di Galeazzo, che a quel tempo vivevano nella città lagunare da poco unita alla terraferma dal ponte fatto costruire dal Duce nel 1933.3 Marcello era felice di trovarsi in vacanza in un posto così bello, dove nessuno ti perseguitava e dove poteva – lo avrebbe fatto una volta imparato a nuotare – fare il bagno nei canali secondari, dando la caccia a gamberetti e pesciolini che allora abbondavano in una Laguna dalle acque cristalline.
Tuttavia, il problema più grande era la noia. Unico nipote (i cugini stavano a Padova), senza amici, era faticoso attendere settembre e il rientro a casa. Dunque i nonni presero l’abitudine di spedirlo in «colonia», cioè una sorta di campeggio statale in strutture appositamente costruite lungo il litorale o in montagna, sotto l’attenta supervisione di giovani istruttori. Allora la propaganda di regime era pervasiva ed efficace. In particolare, i più giovani erano indottrinati ad apprezzare le «meraviglie della rivoluzione fascista» e a considerare Benito Mussolini come un capo carismatico, un uomo dalle virtù eccezionali che il buon Dio aveva mandato in terra proprio per salvare l’Italia dal disfacimento a opera dei bolscevichi: che fortuna per il nostro Paese! Eppure, non tutto procedeva sempre come previsto. Un’estate, per esempio, nella colonia (fatiscente) dove Marcello aveva trascorso le vacanze tra adunate mattutine, addestramento militare e allenamenti per costruire un «fisico fascista», ci fu un’epidemia di pediculosi, tutt’altro che infrequente nelle scuole della Penisola. Rientrato a Galatz, la testa rossa di Marcello risultava talmente infestata e sanguinante che, dopo averlo rasato a zero, Aurica eliminò i parassiti rimanenti a uno a uno con una pinzetta. Quindi bagnò uno straccio con dell’aceto e glielo strofinò sullo scalpo ricoperto di ferite e croste provocate dal grattarsi furibondo del figlio. Le grida e i pianti del bambino furono uditi in tutto il quartiere, tanto che qualcuno corse in sinagoga dal rabbino per avvisare che era in corso un pogrom contro gli ebrei. Per fortuna, era stato il sant’uomo stesso a consigliare la procedura, per cui l’allarme fu spento sul nascere.
Al principio dell’estate 1938, subito dopo gli esami di quinta elementare superati da Marcello con esito eccellente, tanto che la maestra aveva suggerito di iscriverlo al ginnasio, i Salom – Galeazzo, Aurica, lo stesso Marcello e Myriam – si imbarcarono, per una volta tutti insieme, sulla nave per l’Italia. Galeazzo ci aveva pensato a lungo e aveva preso quella decisione soprattutto per il clima sempre più tossico nei confronti degli ebrei. Non passava giorno che alla radio non si udisse la voce stentorea e inconfondibile di Adolf Hitler che vomitava invettive e minacce contro gli ebrei, responsabili di tutti i mali del mondo e, in particolare, delle sofferenze dei tedeschi. Da un po’ di tempo, in realtà, anche in Italia la propaganda fascista aveva iniziato ad attaccare gli «appartenenti alla razza ebraica», sconfessando le parole pronunciate solo quattro anni prima, nel 1934, da Benito Mussolini, di fronte al giornalista Indro Montanelli, ricevuto a Palazzo Venezia: «Il razzismo è una cosa da biondi!». Ma ascoltate qui e là, visto che i giornali nazionali faticavano ad arrivare a Galatz, o sentite nei resoconti familiari le rare volte che arrivava una lettera, per gli ebrei italiani le cose sembravano comunque di gran lunga migliori. E poi c’era quel tarlo che continuava a scavare nella coscienza del capofamiglia, il desiderio inconfessato di farla finita una volta per tutte con le discriminazioni, con l’idea di «essere diversi» dal resto dei cittadini: «Siamo italiani, noi, e basta» mormorava tra sé e sé Galeazzo quando veniva sollevata la questione dell’identità, delle differenze tra Romania e Italia. Nel 1938, insomma, ormai distaccato dagli altri membri della famiglia padovana, Galeazzo si sentiva fisicamente e culturalmente lontano da quella particolare forma di appartenenza religiosa.
Per lui contava soltanto l’identità italiana (e fascista): l’avrebbe fatta prevalere su tutto il resto. E, in un mondo dove l’essere ebrei cominciava a rappresentare un serio pericolo, non c’era che un modo: convertire moglie, figli e sé stesso al cristianesimo. Una volta battezzati, una volta abbracciata Santa Madre Chiesa, tutto sarebbe cessato all’istante. L’imminente promulgazione delle leggi razziali in Italia e la Notte dei cristalli in Germania lo avrebbero convinto in via definitiva del suo passo. Ma in Romania, dove i Salom vivevano a stretto contatto con i suoceri Nathansohn, quell’idea restava confinata nella mente di Galeazzo, sempre più a disagio nei panni in cui il destino lo aveva costretto: in fondo non aveva scelto lui di nascere ebreo, però, pensava, avrebbe almeno potuto cambiare il proprio futuro.
PAOLO SALOM, (Ancona, 1962) è giornalista professionista dal 1991: ha lavorato per diverse riviste su temi di politica estera. Dal giugno 2000 lavora al «Corriere della Sera». Sinologo, autore dell’ebook Fukushima e lo tsunami delle anime (2012), ha scritto quattro monologhi per il Teatro No’hma di Milano e saggi sulla Cina.
Ti è piaciuto questo articolo?
Per continuare a offrirti contenuti di qualità MicroMega ha bisogno del tuo sostegno: DONA ORA.